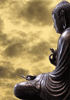Vi è stata una lunga e radicata tradizione di pensiero in Occidente che ha interpretato il buddhismo come una dottrina pessimistica e nichilistica, negatrice del mondo e proponitrice di un annullamento, di un dissolvimento totale dell’individualità. Solitamente poi, e curiosamente, questa interpretazione si accompagnava ad un’altra che poneva l’ideale di liberazione buddhista, ossia la realizzazione dello “spegnimento” o “estinzione” (nibbâna), come il risultato di un atto estremo di egoismo. Illustre rappresentante di questa tradizione fu Max Weber, il quale ancora negli anni Venti del secolo appena trascorso scrisse:
Vi è stata una lunga e radicata tradizione di pensiero in Occidente che ha interpretato il buddhismo come una dottrina pessimistica e nichilistica, negatrice del mondo e proponitrice di un annullamento, di un dissolvimento totale dell’individualità. Solitamente poi, e curiosamente, questa interpretazione si accompagnava ad un’altra che poneva l’ideale di liberazione buddhista, ossia la realizzazione dello “spegnimento” o “estinzione” (nibbâna), come il risultato di un atto estremo di egoismo. Illustre rappresentante di questa tradizione fu Max Weber, il quale ancora negli anni Venti del secolo appena trascorso scrisse:
la stessa interpretazione fu ripetuta anche da noti studiosi indiani di religione hindu, come ad esempio Tirupattur R. V. Murti:
La curiosità di questa interpretazione sta nel suo ondeggiare, assai incoerentemente, fra una visione sostanzialistica ed una nichilistica del buddhismo, ossia fra una visione del buddhismo come “egoismo spirituale” ed una visione di esso quale assoluto negatore dell’io, dell’individualità. Lewis Mumford, seguendo questa linea di pensiero, motivò addirittura la diffusione del buddhismo in Occidente con il suo essere un’ideologia perfettamente funzionale all’odierna società ipertecnologica, completamente anonima e automatizzata, da egli battezzata “la megamacchina”:
Ancora più curioso, però, è che da questo tipo di fraintendimenti il buddhismo fu costretto a difendersi già ai tempi della predicazione del Buddha, contrappondendovi la ben nota dottrina della “via di mezzo” (majjhimâ patipadâ) fra gli estremi (antâ) dell’essere e del non essere, dell’eternalismo (sassatavâda) e del nichilismo (ucchedavâda):
Che le cose abbiamo essere, o Kaccâna, costituisce un estremo; che le cose non abbiano essere, l’altro estremo. Questi due estremi, o Kaccâna, sono stati evitati dal Tathâgata e questa è la via media che egli insegna.
Eppure la ragione dei frequenti fraintendimenti non può essere imputata esclusivamente ad una ignoranza degli interpreti. Vi è in effetti un tipo di linguaggio nei testi canonici del buddhismo che si presta all’incomprensione. Le prime due “nobili verità” (ariya saccâni) del buddhismo enunciano che l’esistenza è “dolore” (dukkha) e che la causa del dolore risiede nel “desiderio” (tanhâ). Abbondano inoltre nei testi i passi che invitano a vedere il mondo sotto il segno della caducità (anicca) e della insostanzialità (anattâ) o vacuità (suññatâ), sia esterna (l’impermanenza di qualsiasi oggetto o evento) che interna (l’assenza di un io in quanto entità stabile e distinta), sia spaziale che temporale:
A tutto ciò si aggiunge la descrizione della condizione di affrancamento dal dolore dell’esistenza come quella di uno stato “sopramondano” (lokuttara), ossia trascendente il “mondo” (loka) e tutto ciò che è “mondano” (lokiya):
Io vi annuncio questa liberazione dal mondo che vi ho esposto secondo realtà: così ci si libera dal dolore.
Come comportarsi di fronte a queste parole? La tentazione più naturale sarebbe di interpretarle come una manifestazione di dualismo, di disprezzo verso la realtà e di fuga verso un altrove che assume i connotati dell’annullamento totale della vita e delle sue gioie. Ma il farlo sarebbe come estrapolare un frammento di un discorso pretendendo di intenderne il senso a prescindere dal contesto in cui si trovava inserito.
Una prima e più generale condizione indispensabile per ricostruire l’autentico significato e la reale portata di questi insegnamenti consiste nella necessità di liberarsi dall’idea che il buddhismo sia interessato a fornire una dottrina precostituita, una serie di teorie in cui credere ciecamente ed a cui affidarsi per avere una interpretazione corretta della realtà. Il Buddha, in quanto ha potuto vedere la natura della realtà, non ha teorie, non ha opinioni ed il suo insegnamento (Dhamma) fornisce semplicemente uno strumento di liberazione che una volta assolto il proprio compito va di necessità abbandonato, come una zattera la quale una volta trasportatici sull’altra sponda del fiume è cosa saggia abbandonare sulla riva raggiunta piuttosto che trascinarsi inutilmente sulle spalle.
Ma se l’insegnamento buddhista è solo lo strumento, quale sarà il fine che esso si prefigge di realizzare? Anche in questo caso il Buddha si è dimostrato molto chiaro fin dal principio: il fine è la liberazione da dukkha, parola variamente tradotta con “dolore”, “sofferenza” o “pena”, ma che forse sarebbe più corretto rendere con “insoddisfazione”, per sottolinearne la valenza mentale: “O monaci, io annuncio una sola cosa: la sofferenza e la cessazione della sofferenza”.
Tale “insoddisfazione” esistenziale non ha però una portata meramente psicologica; essa è il risultato di una fondamentale “ignoranza” (avijjâ) che produce dal punto di vista gnoseologico una “falsa visione” (micchâ ditthi) della realtà di tipo dualistico e dal punto di vista etico un comportamento viziato da una insaziabile “sete” (tanhâ) di possesso di tipo egoistico. È chiaro dunque come nel buddhismo gli aspetti psicologico, gnoseologico ed etico siano inestricabilmente legati.
L’ignoranza fondamentale combattuta dal buddhismo e origine della sofferenza consiste nell’attribuire alla realtà, esteriore ed interiore, delle caratteristiche che essa non ha e non può avere, ossia permanenza e sostanzialità assolute. L’afferrarsi a questo o a quell’altro aspetto dell’esistenza, o anche ad essa nel suo insieme, in conseguenza di tale ignoranza produce inevitabilmente insoddisfazione nel momento in cui la realtà psicologica o materiale a cui ci siamo aggrappati rivela la sua reale natura diveniente ed interrelata, facendo svanire le nostre illusioni. L’oggetto principale di questo afferrarsi o aggrapparsi (upâdâna) è costituito dall’io (attâ), che noi tendiamo in tal modo ad ipostatizzare quale realtà assoluta, stabile e separata dal mondo esterno. Quando i cinque aggregati psicofisici (khandha) che nel buddhismo formano tradizionalmente l’individualità umana diventano oggetto del nostro attaccamento si trasformano negli “aggregati dell’attaccamento” (upâdânakkhandha), fonte primaria della nostra insoddisfazione, nucleo principale intorno al quale coaguliamo ed incrementiamo una visione dicotomica della realtà inevitabilmente guidata da una sete di possesso. “Sete” è in effetti la traduzione più corretta per la parola pâli tanhâ solitamente resa con “desiderio”; si tratta infatti non di un desiderio normale, per il quale in pâli si utilizza il termine chanda, ma di una brama, di un desiderio squilibrato e smodato frutto dell’incapacità di mettere a fuoco la vera natura della realtà. È questo tipo di desiderio che il buddhismo mira ad eliminare, e non il desiderio tout court. In termini cristiani esso è paragonabile alla epithymía, che la teologia latina traduce con concupiscentia, o alla philautía, l’amore di sé opposto all’amore di Dio e del prossimo, della patristica orientale.
Generalmente chi interpreta il buddhismo quale dottrina pessimistica si sofferma sulla fase diagnostica, quella dell’esistenza dell’insoddisfazione, e non pone invece in rilievo come il buddhismo sostenga di fornire dei mezzi per porre fine a tale condizione e come il nibbâna consista appunto nella realizzazione del supremo bene e della suprema beatitudine (paramam sukham). Il fatto poi che la sofferenza non costituisca la natura originaria della realtà è testimoniato dal fatto che il nibbâna è paragonato al vedere la realtà “così com’è” (yathâbhûtam). Se dunque si tratta solamente di riacquisire una condizione originaria e sempre presente è chiaro che tutto quello che bisogna fare è spogliarsi della sovrastruttura del dolore, distaccarci dalle nostre false concettualizzazioni, guardare la realtà al di là delle nostre speranze o delle nostre paure, affinché il nibbâna sia sperimentabile qui e ora in tutta la sua immediatezza:
Se però, come abbiamo veduto, la sofferenza che permea la realtà non è costitutiva ma solo sovrastrutturale, se il desiderio che bisogna eliminare è solo quello egoistico frutto di una visione dualistica e sostanzialistica della realtà, e se l’io di cui il buddhismo dichiara l’inesistenza non è l’individualità empirica ma l’idea di un ego separato dal resto della realtà e permanente, resta allora da chiarire perché nel buddhismo il nibbâna sia considerato uno stato sovramondano e perché si parli della condizione di liberazione dalla sofferenza come di una fuga dal mondo. L’equivoco principale è di tipo linguistico ed è causato dal fatto che spesso nei testi buddhisti i temini del linguaggio ordinario assumono un significato differente e traslato. Nel caso della parola “mondo” (loka), essa assume il significato di percezione ordinaria della realtà, di visione determinata dall’ignoranza, e diviene perciò sinonimo di sofferenza. Come scrive Buddhadâsa:
È chiaro, allora, che se “mondo” e “insoddisfazione” sono equivalenti, se la visione “mondana” non è altro che lo sguardo ignorante sulle cose, la cessazione o l’abbandono di essa non costituisce una fuga dall’esistenza ma un distacco da una percezione errata della realtà, attuato il quale l’esistenza può riacquistare tutta la sua felicità e la sua gioia (sukham) ed è possibile “dimorare beatamente nelle cose così come sono”. Un po’ come nel cristianesimo, in cui la condanna della “carne” (sárx) non è la condanna del corpo, bensì di un rapporto sbagliato e ingannevole col corpo e dove lo scopo dell’ascetismo corporale, come ha ben illustrato Evelyn Underhill, era la morte (la mortificazione) non del corpo, ma dell’egoismo, dell’io inteso nel suo ristretto senso individualistico e posto al centro del mondo, ossia di un’immagine irreale di se stessi e della realtà tutta.
L’esercizio della visione della realtà quale evento caduco e privo di entità sostanziali e separate fa dunque parte degli strumenti, degli abili mezzi (upâyakosalla), messi in atto dal Buddha per condurre il discepolo a spogliarsi da tutte le sovrastrutture – prima fra tutte quella del proprio ego – con cui egli cerca di ingabbiare la realtà. Spogliarsi del “mondo” è spogliarsi del proprio ego (ahamkara), della propria visione dualistica, del senso dell’io-mio, abbandonare tutti gli attaccamenti, svuotarsi da tutte le costruzioni mentali, purificare la propria mente, il proprio cuore, fino a che diventi specchio terso in cui la realtà possa riflettersi quale veramente è:
Questa è la condizione più volte descritta come “indifferenza” o “imparzialità” (virâga) e riassunta dalla frase: “nessun dhamma a cui aggrapparsi”. Dhamma, nel buddhismo, è forse la parola dal significato più ricco. Essa indica tutti gli elementi dell’esistenza ed anche la stessa dottrina buddhista. Perciò, dire “non attaccarsi ad alcun dhamma”, equivale a dire: “non attaccarsi a nulla”. E non aggrapparsi a nulla vuol dire anche “non aggrapparsi neppure al non attaccarsi a nulla”. Attaccarsi al non-attaccamento, ossia all’indifferenza, infatti, è la più sottile e difficilmente sradicabile forma di attaccamento. È per questo che la purificazione e lo svuotamento messi in atto dal discepolo sono talmente profondi e completi da prevedere l’evacuazione della stessa idea di vacuità, ossia il distacco dalla stessa idea di non-attaccamento, di indifferenza, come ultimo e più subdolo legame su cui può far presa il proprio ego. Ciò fa sì che non si possa nemmeno dire, del liberato (vimutta), che egli combatta il “mondo”, ossia la sofferenza, perché egli ha oramai superato qualsiasi forma di dualismo e di opposizione tipici della visione “mondana”, compresa quella fra sofferenza e liberazione: “io non combatto con il mondo, ma il mondo combatte con me; poiché colui che conosce il Dhamma non combatte mai con il mondo”.
Resta da fugare un ultimo fraintendimento cui può dar luogo l’esposizione della dottrina buddhista, e cioè l’impressione che questa “indifferenza” non sia altro che una condizione di estrema insensibilità, un freddo ed apatico distacco incapace di alcun sentimento. Non si comprenderebbe però, in questo modo, perché invece la condizione di liberazione (vimutti) nel buddhismo sia vista come lo stato in cui benevolenza (mettâ), compassione (karunâ), gioia (muditâ) ed equanimità (upekkhâ) sono presenti e sviluppate nel loro grado più alto.
L’imperturbabilità o, per usare un termine di origine stoica ma che si ritrova anche in molti padri della Chiesa (Clemente Alessandrino, Origene e Gregorio di Nissa fra questi), l’apátheia, ha sempre suscitato perplessità se non avversione nel mondo occidentale. È nota ad esempio l’aspra critica di Girolamo, il quale nel Dialogus adversus Pelagianos avanzò l’ipotesi che gli asceti intendessero mutare l’uomo in una pietra senza più alcun sentimento umano, contraddicendo in questo modo il primo e più fondamentale comandamento cristiano. La difficoltà di conciliare impassibilità e compassione, imperturbabilità e benevolenza, indifferenza e gioia simpatetica è sempre stato anche uno dei problemi maggiori per gli esegeti occidentali del buddhismo; ma se amare vuol dire affrancarsi dagli attaccamenti esteriori e interiori, dalle passioni individualistiche che continuamente riproducono quella dualità, quell’egoismo, quelle opposizioni che sono la principale causa dell’odio, dell’ignoranza e quindi della sofferenza, allora possiamo comprendere come la condizione di imperturbabilità e di imparzialità sia la condizione spirituale indispensabile per amare e conoscere veramente, poiché in essa si realizza la limpidezza mentale ed emotiva necessaria affinché ogni cosa possa riflettersi in noi secondo la sua reale natura, cosicché noi possiamo accoglierla ed amarla in modo in-differente, ossia al di là di qualsiasi differenza creata dal mutevole gioco delle nostre contrastanti passioni.