Buddhismo zen e pratica scientifica
Un approccio sostenibile al dialogo fra religione e scienza
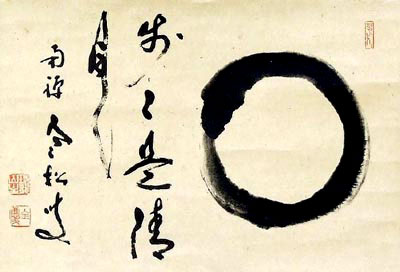
2. I caratteri originari del Buddhismo
Luigi Cerruti
Università di Torino
e-mail: luigi.cerruti@unito.it
Il Dharma ha il duplice inscindibile carattere di essere trascendentale ed empirico al tempo stesso. Nell’appello a lasciare i cattivi maestri il Buddha invita i futuri discepoli a mettere alla prova l’insegnamento, e di seguirlo soltanto se essi sentono che il Dharma li porta nella pratica lontano dal male e verso il bene (su questo appello insisterò fra poco).
Per pratica si intende sia la vita quotidiana, sia la meditazione formale. Il carattere trascendentale dell’insegnamento traspare nel fatto che essendo ogni cosa priva di un sé permanente, si scopre non senza ripulsa che la vacuità di tutte le cose riguarda anche se stessi. In pā²i si esprimono nitidamente i tre segni di ogni essere: anicca (impermanenza), dukkha (pena, sofferenza, dolore, insoddisfazione), anatta (assenza di un sé, di qualsiasi essenzialità). Sull’impermanenza e la sofferenza del nostro essere gettati nel mondo non si può dubitare; è anatta, l’assenza di un sé, che spesso si dimostra essere l’ostacolo insormontabile per l’accettazione esistenziale di una pratica autentica. Su questa affermazione del Buddha è in corso da migliaia di anni una interminabile ricerca. Sottolineo che l’aggettivo ‘interminabile’ va preso in senso stretto. La percezione dell’io con cui un singolo individuo si identifica cambia durante tutta la sua vita. In epoche lontane nel tempo e di diversa civiltà, nelle diverse classi sociali la percezione dell’io/sé è sempre stata diversa. Quindi diverse sono state le opinioni sulla ‘consistenza’ dell’io/sé. Per comprendere quali grandi differenze vi possano essere possiamo riferirci a situazioni culturali in cui siano presenti o non presenti riferimenti a componenti dell’io/sé ritenuti immortali come l’atman del vedanta, o l’anima dei cristiani. Nel Dhammapada, una antologia poetica che appartiene agli strati più antichi dei testi canonici, si trova un riferimento importante per i Buddhisti di ogni denominazione.[[Esistono tre testi ‘originali’ del Dhammapada, in pā²i, sanscrito e pracrito. Sotto questo nome il Canone cinese contiene quattro traduzioni condotte su quattro diversi ‘originali’ sanscriti. Gli studi comparativi hanno dimostrato che non vi sono discrepanze significative fra i veri testi; cfr. Sangharakshita 1985, 46, op. cit..]] Alla strofa 279 si legge:
-*“Tutti gli elementi sono privi di un sé: quando si vede questo con l’occhio della saggezza/allora se ne ha abbastanza della sofferenza: questo è il cammino della purezza”.[[Sabbe dhammā anattā ti yadā paññāya passati /atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyā. Tr. in Martinelli L 1990, 139, op. cit. Le citazioni dei testi in pā²i sono tratte dall’edizione elettronica del Pāḷi Tipiṭaka edito in rete all’indirizzo: http://www.tipitaka.org. Ricordo che il pā²i è una lingua colta, mai parlata nella vita quotidiana, evolutasi nel corso di secoli proprio nel tramandare, commentare ed estendere l’insegnamento del Buddha. Il pā²i non ha un alfabeto proprio, per cui le trascrizioni con alfabeto latino hanno la stessa dignità delle trascrizioni in alfabeto devanāgarī.]]
La strofa 279 è la terza di tre, in cui il Buddha invita a vedere mediante la saggezza (paññāya passati) le tre caratteristiche dell’essere. Le prime due caratteristiche sono attribuite a tutto ciò che è formato, costituito, composto, condizionato (saºkhāra). La strofa 277 inizia con sabbe saºkhārā aniccā, “tutto ciò che è condizionato è impermanente”; la strofa successiva inizia con sabbe saºkhārā dukkhā, “tutto ciò che è condizionato è penoso”. Martinelli traduce con ‘elementi’ la parola dhammā perché nel trasporre una poesia da una lingua all’altra è necessario fare scelte drastiche, e non avrebbe potuto inserire una frase del tipo “tutto ciò che esiste, concreto o pensato, è privo di un sé”. Più volte, in incontri fra Buddhisti, ho ricordato la frase canonica sabbe dhammā anattā, e ho potuto constatare che spesso le interpretazioni cercano altrove un rifugio che non condanni il proprio sé a scomparire dopo la morte. Si tratta di un locus classicus impervio e inospitale. Vi tornerò al termine della relazione, quando affronterò alcuni aspetti del rapporto fra conoscenza scientifica e (possibile) pratica di risveglio.
Non credo che esista altra religione che neghi con pari decisione l’esistenza di un sé permanente, ma vi è un altro tratto del Dharma che mi pare veramente unico: la necessaria libertà di ricerca etica ed esistenziale. [[Sul ruolo della meditazione in questa ricerca vedi Cerruti L. 1999.]] A proposito di questa libertà possiamo commentare un passo diventato famoso dopo che l’insegnamento del Buddha è giunto in Europa. Per millenni l’invito del Risvegliato (Kesamutti Sutta, Aºguttara Nikāya, III. (7). 66) [[Il Sutta è numerato come 66 nel Tipiṭaka tailandese qui citato. Altrove è numerato come 65.]] non ha attratto l’attenzione degli studiosi e dei praticanti. Poi, nel clima culturale e politico europeo il brano è stato riletto come un manifesto per la libertà di pensiero.
I Kālāmā erano una delle tanti genti incontrate dal Buddha nella sua quarantennale predicazione. A dire il vero furono i Kālāmā ad andare incontro al Risvegliato, non appena ebbero notizia dell’arrivo del famoso asceta a Kesaputta, la loro città. Non tutti i Kālāmā resero omaggio l’asceta nello stesso modo, il sutta elenca cinque modi diversi di saluto, graduati dallo scambio di parole amichevoli, al gesto rispettoso a mani giunte, al sedersi in silenzio a lato del Buddha. Ma la folla dei Kālāmā aveva un problema: molti asceti e sacerdoti avevano predicato nella loro città prima del Risvegliato, e tutti avevano proclamato la verità della propria dottrina, e negata la verità salvifica degli altri insegnamenti. Così la domanda all’ultimo venuto era stata questa: come possiamo distinguere la verità dalla menzogna? La risposta del Buddha fu tagliente, come l’incisione di un chirurgo su un bubbone:
-*“Eccovi, Kālāmā, [la risposta]: no, non con la rivelazione, non attraverso la tradizione, non per il sentito dire, non per ciò che è nelle scritture, non ragionando logicamente, non aderendo ad una scuola di pensiero, non per delle buone ragioni, non per l’accordo con un punto di vista, non per via di una persona competente e capace, non perché il nostro asceta è un maestro. Quando voi stessi Kālāmā sapete che queste cose non sono salutari, queste cose sono condannabili, queste cose sono condannate dai saggi, queste cose, intraprese e osservate, portano a danno e sofferenza, allora abbandonatele”. [[Etha tumhe, Kālāmā, mā anussavena, mā paramparāya, mā itikirāya, mā piÂakasampadānena, mā takkahetu, mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā diÂÂhinijjhānakkhantiyā, mā bhabbarūpatāya, mā sama¼o no garūti. Yadā tumhe, Kālāmā, attanāva jāneyyātha: «Ime dhammā akusalā, ime dhammā sāvajjā, ime dhammā viññugarahitā, ime dhammā samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saμvattantī» ti, atha tumhe, Kālāmā, pajaheyyātha. Ho tradotto la prima parte del testo – la più controversa – basandomi sull’analisi di Jayatilleke che discute a fondo ogni singolo termine dei dieci enumerati dal Buddha: Jayatilleke K.N. 1998, passim, op. cit. Per la seconda parte mi sono appoggiato alle traduzioni quasi letterali, ma in diversi punti differenti, reperibili all’URL: http://www.accesstoinsight.org ]]
La prima parte del brano elenca dieci negazioni che meritano di essere riprese e commentate singolarmente. La parola mā che scandisce il testo è in pā²i un avverbio di negazione, però mentre l’analogo avverbio na indica negazione semplice, mā ha in sé uno specifico e più forte aspetto performativo di proibizione, di non fare. Il primo monito del Buddha ai Kālāmā va subito al cuore della situazione religiosa e sociale in cui si collocava l’esposizione del Dharma. La società indiana era strutturata in rigide caste, giustificate, anzi reificate dalla tradizione (anussava: tradizione rivelata) dei Veda; e l’asceta giunto a Kesaputta si era instancabilmente pronunciato contro qualsiasi diritto di nascita; un uomo era nobile se il suo comportamento era nobile, non perché era nato in una certa famiglia. Non meraviglia se alla richiesta di indicare come giungere alla verità la prima risposta del Risvegliato sia mā anussavena “non mediante la rivelazione”. La seconda negazione riguarda paramparā la tradizione nel senso più terreno di insegnamento trasmesso da un insegnante ad un allievo.
Mā itikirāya intima intima di non dare una fiducia acritica a itikirā, il sentito dire, il riportato da altri (compresi gli storici), o anche l’opinione comune. Mā piÂakasampadānena è forse l’espressione più sorprendente da leggere in un testo sacro perché significa “non sulla base dell’autorità dei testi sacri”. Anche quanto si legge nel TipiÂaka o in altri testi sacri non è di per sé una soluzione ai problemi etici ed esistenziali. Le successive quattro negazioni si riferiscono a forme di pensiero: takka, la ragione, la logica; naya, l’analisi filosofica; ākāraparivitakka, le ‘buone’ ragioni, il senso comune; diÂÂhinijjhānakkhanti, l’accordo convincente con una propria teoria. Le ultime due negazioni chiamano in causa direttamente i maestri che si possono incontrare: non è sufficiente che la guida sia una persona competente (bhabba) o un asceta (sama¼a) come il Buddha stesso.
La seconda parte del brano del Kesamutti Sutta non richiede particolari chiose. In tutto il Dharma risuona l’opposizione kusala vs. akusala; a seconda dei contesti kusala può significare intelligente, abile, esperto, oppure (di un atto) buono, giusto, meritorio. In senso soteriologico la traduzione che sento più vicina è salutare, e akusala diventa non salutare. Per farla breve, secondo il Buddha, la guida principale per la ricerca interiore si ha negli esiti pratici di ciò che si fa, si dice, si pensa. Se da una pratica deriva danno e sofferenza, la pratica va abbandonata.
____________

